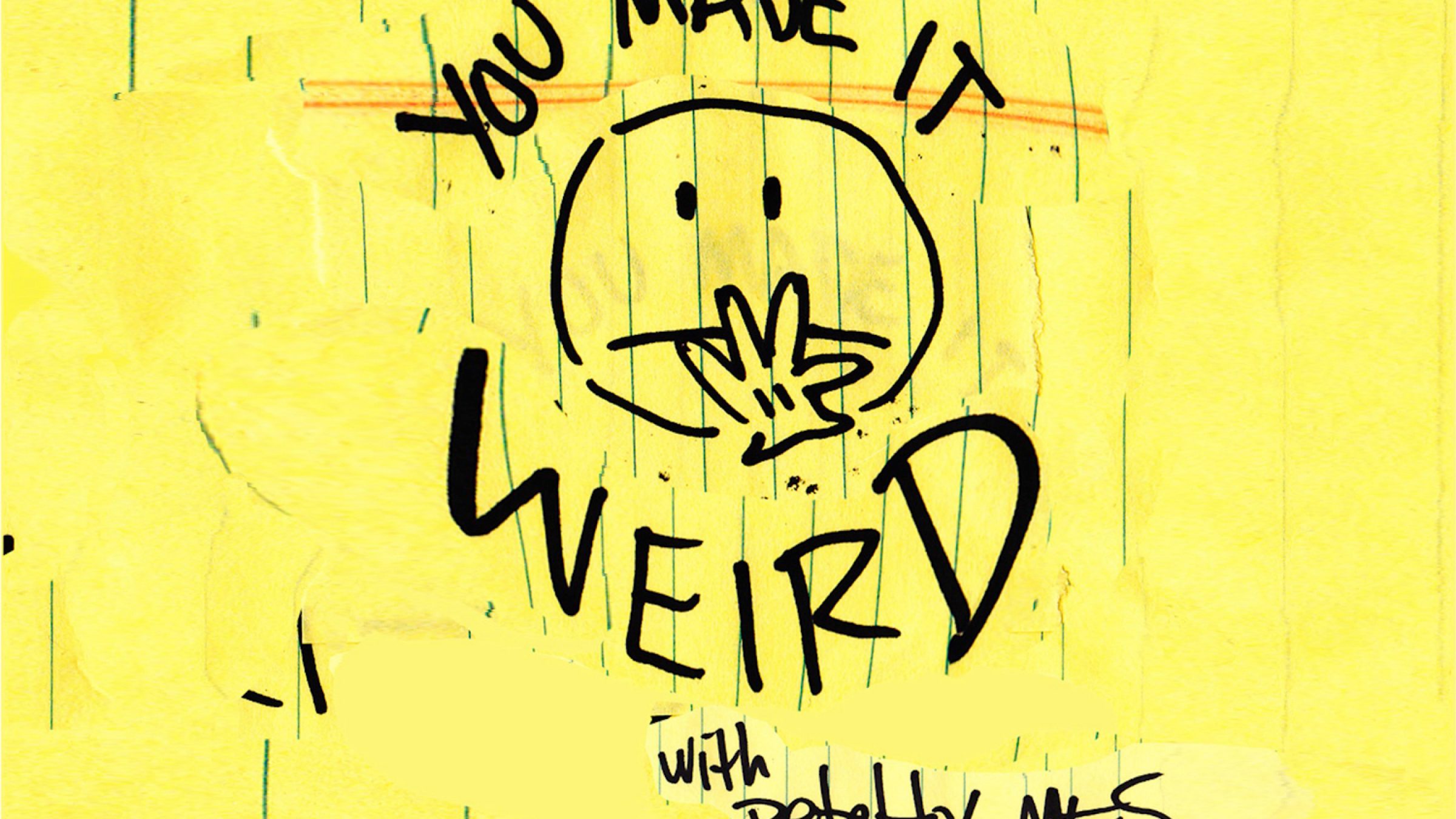
Dietro al microfono intimo del podcast, sempre più comici statunitensi raccontano le loro debolezze, dipendenze, strane abitudini. Perché lo fanno?
Le nostre vite vanno sempre peggio. Ve ne siete accorti? Ve ne siete accorti. Non parliamo d’altro, in effetti. Si può dire che, arrivati a questo punto, è stata maturata la consapevolezza di attraversare un momento di generica infelicità collettiva, per qualcuno sicuramente aggravata da vicende personali quasi impossibili da raccontare, per qualcun altro da un senso di isolamento invincibile. Magari i nostri problemi sono quelli di tutti, però sono anche i nostri, e questo li rende, se non più urgenti, più reali. Un esercizio utile potrebbe essere il chiedersi a quale punto, per noi, è cominciato lo scivolone nel peggio – ieri? cinque anni fa? lo scorso autunno? – e mettere a confronto il risultato con il momento in cui si è iniziato a seguire uno tra i tanti podcast dove gli attori comici vanno a confessare i loro peccati.
Il formato, a grandi linee, è stato tenuto a battesimo da Marc Maron nel 2009, con la prima stagione di WTF. Maron ha progettato il podcast come una conversazione a briglia sciolta tra adulti, a partire da quello di cui aveva bisogno lui – un posto sicuro dove parlare di fallimenti, reali o percepiti, nella prospettiva di un comico quarantenne ex alcolista ed ex cocainomane – e un pezzo alla volta ha costruito una macchina da guerra, il posto dove i comici si raccontano. Ma oggi gli accessi possibili, per chiunque di mestiere faccia ridere e voglia condividere un po’ dei suoi guai, sono tanti. Per cui se sei famoso e hai una storia personale spendibile (oltre che un oggetto da promuovere) te ne vai dritto da Maron, che è la porta principale: se sei meno famoso ma pronto ad appoggiare una gamma di traumi sul tavolo c’è Mental Illness Happy Hour, mentre se non sei famoso ma hai un profondo serbatoio di conoscenza sulla pazzia degli altri c’è Lizard People, podcast dedicato alle cospirazioni e alla gente che ci crede; se sei famoso agli occhi di un gruppo di persone e sei pronto a metterti a nudo contando sull’empatia del conduttore c’è The Nerdist, almeno ogni tanto, e se sei famosino – o se ti si può considerare un astro nascente – e vuoi parlare delle tue stranezze c’è Pete Holmes che ti riceve a You Made It Weird. È quasi consolante, la varietà di location.
In sottofondo passa sempre lo stesso messaggio: siamo tutti fragili, siamo tutti emotivamente precari. Il nostro è un mondo brutto, deforme, pieno di dolori rimossi che presto o tardi vengono alla superficie. Però allo stesso tempo facciamo anche parte di un vero universo narrativo: viviamo in mezzo a una trama di storie personali, mandata avanti dalla fiducia nel proprio essere strani, dalla speranza materiale che là fuori siano tutti un po’ strani, meno compatti e risolti di come amino presentarsi.
Una comunità tra chi parla e chi ascolta
È obbligatorio usare il “noi”, qui, non perché si debba essere d’accordo o ritrovare se stessi in quello che viene raccontato, ma perché il “noi” è invocato da chi queste storie le racconta e le ospita: il fatto personale, quasi un memoir in miniatura, è sempre inserito nell’abbraccio del “noi” in ascolto. Tu ti fidi di noi / noi ti accogliamo, ti celebriamo, ti sosteniamo, ti portiamo in trionfo per un certo arco di tempo. Siamo una famiglia. Allora i podcast comico-disfunzionali si possono leggere come una grande narrazione a puntate, dove i personaggi vanno, vengono e ritornano – l’industria in questo è bravissima, maestra: da un lato, capita spesso che un ospite eccezionalmente bruciante venga invitato di nuovo per aggiornare gli ascoltatori e il conduttore; dall’altro, chi conduce lì va ospite là, e sceglie cosa raccontare quando, giocando sui tempi diversi. L’uomo che mangiava i Vicodin dei suoi cani ha vuotato il sacco nel podcast di qualcun altro, non nel suo. Intanto i forum dei programmi diventano il teatro di una conversazione tra affezionati membri del pubblico, a metà tra l’auto-aiuto e la gara a chi è più bizzarro, e a volte uno di loro viene pescato dal mucchio, invitato a parlare.
Giocare con i tempi e i ruoli in questa maniera ha l’effetto collaterale di retrodatare il peggio, dargli una prospettiva storica, per così dire. E qui viene davvero da immaginare Maron che allarga le braccia e parla della vita in generale, life. Amici, non abbattetevi, le nostre vite sono sempre state pessime, è cambiato solo il nostro livello di awareness. Perciò il passato è sempre un buon argomento di discussione, molto più del presente. Oggetto di una puntata può essere la litigata con il patrigno intorno al tavolo da pranzo nel 1971, come se stesse ancora accadendo adesso. Oppure, faccio un esempio tratto da Lizard People, si possono sviscerare in chiave brillante le teorie sull’omicidio/suicidio Cobain, che si sono tutte diffuse entro pochi giorni dalla morte del cantante, e hanno prosperato negli anni Novanta, molto prima che Internet facesse da megafono per le fissazioni individuali. Tutto è urgente, o può diventarlo.
Storie estreme e imbarazzanti
In questo scenario, You Made It Weird è la pietra angolare della leggerezza – si va là per raccontare cosa ti rende “strano” in quanto “diverso da tutti gli altri”, e ci si saluta, in teoria, stando meglio rispetto a come si è arrivati – ma può capitare, perché è capitato, che passi da lì qualcuno pronto a rendere tutto molto più oscuro. La puntata famosa, per la gravità della vicenda e per la franchezza con cui il protagonista la raccontava, è stata quella in cui lo sceneggiatore Harris Wittels (Parks and Recreation) parlava dei suoi problemi di droga, cominciati con un consumo di Oxycontin eccessivo ma ancora a grandi linee definibile “ricreativo”, più o meno, e terminati bucandosi di eroina con una siringa che aveva imparato a prepararsi grazie ai video-tutorial su YouTube, oltre ai suggerimenti di un senzatetto. Harris non era simpatico e non generava particolare identificazione in chi non era passato esattamente da dove era passato lui, ma suonava genuino nella maniera con cui rispondeva alle domande del conduttore preoccupato, e risultava molto reale, naturale, per il misto tra incertezza e ottimismo con cui guardava al futuro. Era appena uscito dal secondo ricovero, stavolta legato all’eroina. È morto tre mesi più tardi per overdose. La puntata è la più dolorosa tra le tante storie weird raccontate in quel programma – io ho finito per riascoltarla ogni anno tra Natale e San Silvestro – ma nel grande schema della narrazione tramite podcast non è la più estrema, o la più imbarazzante. Non è niente, rispetto a certe storie vere di WTF, o all’uomo che si mangiava i Vicodin dei suoi cani ed è sopravvissuto per raccontarlo (Greg Behrendt, per come si è portato in scena durante un episodio di The Nerdist).
Da quando vogliamo che il comico sia una rockstar intossicata e dolente, con, se possibile, ancora meno risorse per cavarsela? Da quand’è che noi vogliamo sentirli stare male, non ci basta la performance ben riuscita: vogliamo anche la verità?
Resta da capire, se vogliamo, come mai sia stato proprio il podcast a diventare il mezzo preferenziale per questo genere di confessioni da parte dei comici, superando le serate microfono aperto (che hanno anticipato un po’ la tendenza, ma a parte l’esempio clamoroso di Tig Notaro al teatro Largo tendono a non ospitare confessioni lunghe e dettagliate). In alcuni casi la scelta sarà dipesa da una questione di possibilità concrete – Kulap Vilaysack (Childrens Hospital, Comedy Bang! Bang!) non è ancora un’attrice abbastanza nota da poter finire intervistata in un talk show del pomeriggio, e un’altra valvola di sfogo non ce l’aveva in un determinato momento, quindi, se voleva raccontare le sue tumultuose vicende familiari, dall’arrivo negli Stati Uniti con una famiglia di profughi del Laos alla scoperta che il suo vero padre non era chi credeva lei, non poteva trovare una casa più confortevole e meno giudicante rispetto a una conversazione registrata nel soggiorno di qualcuno. In altri casi, la decisione si baserà sul fatto che il podcast è formato da voci nude, quasi mai filmate, prive di una traccia scritta: questo amplifica l’intensità di una comunicazione improvvisata. Non ci si deve preoccupare di come si sta apparendo, o di quali parole si mettano nero su bianco. Si deve arrivare a chi ascolta in base all’energia con cui si rivisitano le proprie ferite.
Lo stesso. Tanto quanto nessun privato cittadino può dire di guadagnarci davvero dall’andare a chiedere aiuto a uno psicologo televisivo in fascia protetta, nessun ospite di un podcast ci guadagna, dal partecipare a questi teatrini, se non la catarsi (forse) o l’esposizione a un pubblico che potrebbe prendere in considerazione il loro lavoro comico perché li ha sentiti raccontare un orribile segreto. No, se mai tirare fuori lo strano equivale a portare nel mondo una verità umana irrinunciabile, e il mandato collettivo di due generazioni di comici diventa essere reali.
Dalle origini a Donald Trump
Allora quando è cominciata la danza, per noi? Da quando abbiamo cominciato a pretendere queste cose dai nostri eroi? Da quando vogliamo che il comico sia una rockstar intossicata e dolente, con, se possibile, ancora meno risorse per cavarsela? Da quand’è che noi vogliamo sentirli stare male, non ci basta la performance ben riuscita: vogliamo anche la verità?
Un primissimo momento da ricordare potrebbe essere stata l’autobiografia di Lenny Bruce, Come parlare sporco e influenzare le persone, uscita a puntate su Playboy tra il 1964 e il 1965. Era il lungo ritratto di una vita costellata da false partenze, arresti per oscenità, abitudini disastrose e matrimoni falliti con spogliarelliste di nome Honey. Sembrava di sentire la voce di Bruce, leggendo. Il testo era ricalcato sul parlato del narratore, e in questo, forse, è stato il primo podcast della storia. Ma arrivava a noi comunque mediato dall’intervento di un co-autore, e arrivava scritto per un pubblico che avrebbe provato interesse a priori nei confronti di un protagonista trasformato in simbolo della lotta contro l’ipocrisia della buona società. C’era un nesso, insomma, tra quanto Bruce raccontava e le aspettative di un gruppo di lettori molto preciso (compro Playboy per le donnine ma anche per gli articoli). Mentre chi oggi si ascolta una puntata di un podcast comico-disfunzionale lo fa in nome di una forte devozione al formato, non al personaggio di turno, e vuole tanto vedere cosa salta fuori a questo giro. Chi si infila gli auricolari per ascoltare, di nuovo, Harris che spiega come è stato fregato da una serie di spacciatori quando ha cercato di procurarsi eroina in un parco di Los Angeles lo fa perché vuole sentire qualcuno che tocca il fondo, certo, ma vuole anche passare il dito sopra la fiamma. Vuole mettere in relazione il proprio disagio individuale a quello di qualcuno che per mestiere dovrebbe far ridere, e vuole sentirsi meno in colpa rispetto a chi guarda i programmi dove telefonano gli spettatori. Vuole il “noi”, insomma. Il “noi” è una sirena irresistibile.
Per alcuni anni, questa bolla poteva sembrare la realtà, tutta quanta. È stata drasticamente ridimensionata dagli eventi. E niente avrebbe potuto far scoppiare la bolla della stranezza come l’ascesa al potere di Donald Trump. Ve li raccomando, i monologhi d’apertura di certe trasmissioni, all’indomani dell’ingresso nel buio del tempo presente. Nell’aria c’era la paura di aver sbagliato tutto, di non aver capito in quale direzione stesse andando la maggioranza delle persone. Gli strani ora non sanno se tornare a essere una minoranza stracciona, con in più il carico della sconfitta, o se continuare a perorare la loro causa. Sta di fatto che mentre a qualcuno poteva sembrare che il mondo stesse prendendo lo stesso colore emotivo – la razza umana come un ammasso di individui fragili, spaventati, ossessionati da tutto, ma ancora aperti alla possibilità di un presente e di un futuro migliore – in parallelo cresceva l’industria dei podcast comici di segno opposto: quella che ospita sempre le confessioni di intrattenitori, ma capitalizza sulla confusione maschile per portare avanti un discorso del genere “non siamo noi che siamo strani, sono le donne a essere ladre e infedeli!”. Se ne è parlato, all’indomani del caso Milo Yiannopoulos, per mostrare come l’altra faccia dell’impero – quella dove sta The Joe Rogan Experience, per citarne uno – fosse dominata dagli uomini arrabbiati che odiano tutti. Però, oggi come ieri, con la stessa facilità, i re del livore militante vanno ospiti nei podcast dei buoni, senza neanche abbassare troppo le penne, a raccontare le loro perdite e le loro cattive decisioni. Come se in vista ci fosse una grande alleanza, a un certo punto lungo la strada. O una frammentazione ancora maggiore.
Violetta Bellocchio
Autrice di Il corpo non dimentica (2014), ha fatto parte di L’età della febbre (2015), Ma il mondo, non era di tutti? (2016), ha curato l'antologia Quello che hai amato (2015) e la traduzione italiana di The Art of Rivalry (2016). Ha collaborato a Rolling Stone, Vanity Fair, IL, Rivista Studio.
Vedi tutti gli articoli di Violetta Bellocchio


