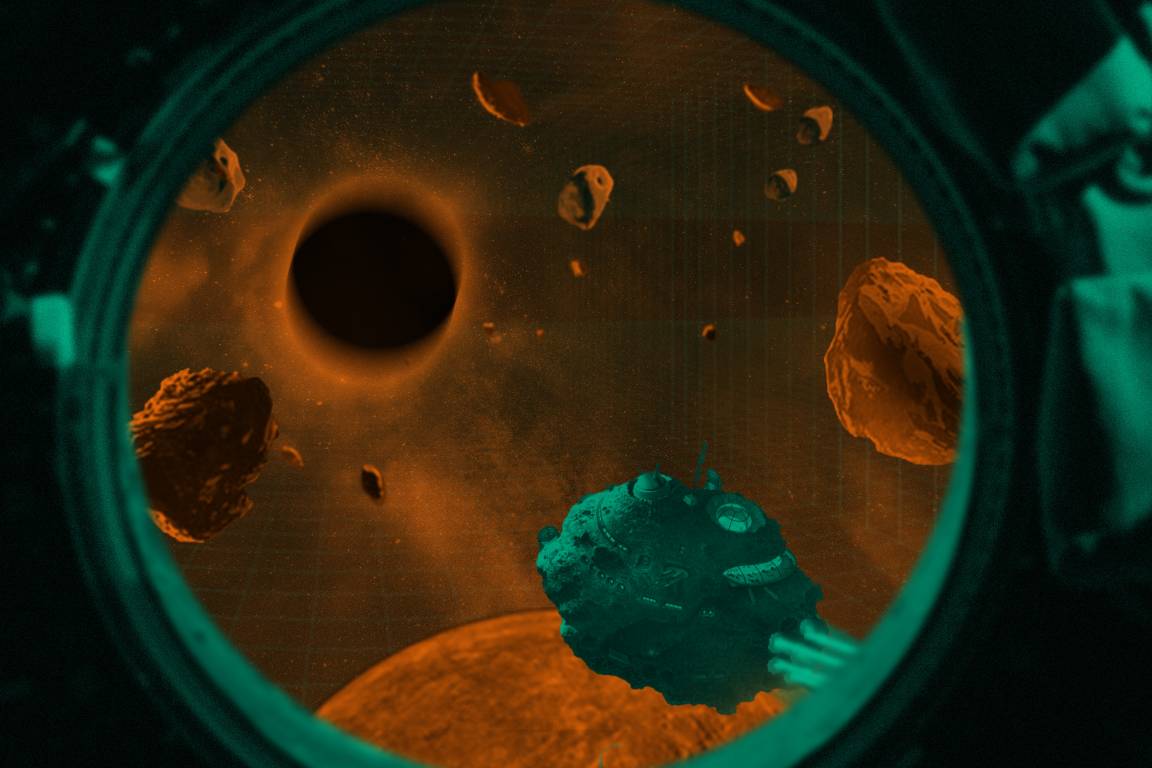Una forma di racconto audio è diventata anche e soprattutto video. Bastano un tavolo, delle cuffie e un grosso microfono per riconoscere immediatamente il tipo di contenuto. Per copiarlo, per imitarlo.
Oggi potrebbe sembrare strano, ma c’è stato un momento in cui i podcast non si vedevano. Si sentivano e basta. Era un medium audio nato dalla fusione tra alcuni elementi tipici della radio e una distribuzione libera via web, di tipo Rss, usando file tutto sommato leggeri che potevano essere scaricati in mp3 (l’ascolto via streaming era più raro) anche grazie a un dispositivo che, nei primi anni del Duemila, stava cambiando le abitudini di milioni di persone, l’iPod. È anche grazie al gadget di Apple che i podcast hanno trovato il loro nome. Prima di allora, erano indicati con un termine molto descrittivo, audioblogs, in quanto versione sonora di un pezzo di internet. Negli ultimi anni qualcosa è decisamente cambiato. Prima sono arrivati i video podcast – che è come dire “radiodrammi visivi”, a questo punto chiamiamoli “film” e basta –, poi TikTok, con il suo formato breve e verticale, che ha trasformato un medium audio donandogli un’estetica molto riconoscibile.
Costruzione di un’estetica
La scena sarà nota ai più: una o due persone parlano sedute su una poltrona da gamer o un divano, davanti a un microfono con asta, preferibilmente uno Shure (à la Joe Rogan) o un Rode. L’argomento? La qualunque: la guerra in Ucraina, gli ufo, un gol della Sampdoria, un complotto antisemita o l’ultimo gossip sui reali inglesi. Poco importa: l’estetica da podcast, nel 2023, è una scatola luccicante il cui tema può variare fino a incorporare tutto. Uno degli esempi più noti di questa voracità di contenuti è uno dei titoli di maggiore successo nel settore, The Joe Rogan Experience, podcast di lungo corso del comico e commentatore tv Joe Rogan, noto per le lunghe interviste a esperti di pseudoscienze, comici, politici, giornalisti e chiunque abbia un’opinione forte su qualcosa. Rogan è diventato il punto di riferimento di un nuovo pubblico globale, perlopiù maschile, muscoloso (o desideroso di diventare tale), machista ma anche avvezzo a consumi “alternativi”, in termini culturali e di sostanze psichedeliche.
Nel 2019, Spotify sborsò una cifra astronomica (superiore ai 200 milioni di dollari, per alcune stime) per i diritti esclusivi dell’Experience sulla piattaforma: erano i primi passi dell’azienda svedese alla conquista del segmento podcast e Rogan era il nome grosso da avere a tutti i costi. Nonostante l’esborso, al comico rimase il controllo del canale YouTube, dove pubblica le puntate intere con tanto di video. Già, il video. Dicevamo della rilevanza anche estetica dello show, che a differenza delle mega produzioni tv ruota attorno a un tavolo di legno in uno studio non troppo grande, caldo, con una sorta di tenda, un drappo rossastro, alle spalle dell’ospite, mentre l’host è illuminato da un neon colorato con il nome del podcast. Sul tavolino, solo i microfoni; sia l’host che l’ospite indossano delle grosse cuffie nere.
Siamo abituati a vedere (e sentire) giornalisti, attori, musicisti, comici parlare di sé e del mondo davanti a quei microfoni. Ci risulta quindi naturale pensare che chiunque sia davanti a uno di quegli stessi microfoni abbia qualcosa da dire. “Ci sarà un motivo se è lì, no?” ci domandiamo. La risposta – potrebbe stupire qualcuno – è no. Non necessariamente.
Pochi elementi che ritroviamo in tutti i podcast con una versione video. Casi come quello di Rogan – ma anche Flagrant di Andrew Schulz o Conan O’Brien Needs a Friend, per arrivare agli italiani Muschio selvaggio di Fedez e Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli – sono ormai produzioni notevoli. E verrebbe da pensare che, con la crescita di questi prodotti, la tendenza sia di usare microfoni piccoli, di tipo lavalier come in televisione, e rimuovere le enormi cuffie. Insomma, un podcast “adulto” dovrebbe darsi un tono, tendere al late show, ma è chiaro che il ricorso a elementi simili, un po’ “improvvisati” nonostante i budget in aumento, sia ormai identitario per il settore. Come se il tipo di conversazioni lunghe e senza filtri che hanno fatto la fortuna di questi show passasse anche per un aspetto formalmente DIY.
La forma è sostanza
L’imposizione di una certa “forma” di podcast ha portato a due conseguenze inevitabili nel momento in cui un prodotto conquista successo e riconoscibilità: la parodia e la copia. Nel primo caso, uno degli esempi più noti degli ultimi anni viene da Inside di Bo Burnham – celebrato speciale comico pandemico tutto girato in una stanza –, più precisamente da una delle scene tagliate e pubblicate in seguito su YouTube. È una satira del modello conversazionale alla Rogan (e in generale del dibattito sul politicamente corretto sulla comicità) in cui compaiono due ospiti (in entrambi i casi Burnham), due microfoni e due cuffie. Ed è subito podcast. (Un altro esempio, più recente, viene da TikTok, dove un giovane comico, Mark Edwards, gioca con i tropi più diffusi di un certo tipo di show).
E poi c’è la copia. C’è chi la fa creativamente, tenendo gli originali a modello per sviluppare un’idea personale, ma anche chi preferisce le scorciatoie. La canonizzazione dell’estetica da podcast ha così aperto le porte allo strabiliante fenomeno dei “podcast finti”, contenuti recenti e bizzarri che si trovano soprattutto su TikTok, i Reels di Instagram e gli Shorts di YouTube, e fanno leva sul potere culturale di questi podcast per guadagnare qualche view. Pochi mesi fa Vshred, controverso influencer statunitense che vende corsi per diventare maschi di successo, ha pubblicato delle pubblicità molto particolari, in cui indossava delle cuffie voluminose e parlava davanti a un microfono Shure con alle spalle un tendaggio rossastro molto roganiano. A un certo punto, grazie alla magia del montaggio, compariva anche lo stesso Rogan, a indicare un botta e risposta tra i due. Che in realtà non c’era mai stato.
Automatismi e imitazioni
Il valore mediale dei podcast non si limita alla notorietà che una puntata di Rogan sembra offrire ai suoi ospiti ma all’estetica in sé: siamo abituati a vedere (e sentire) giornalisti, attori, musicisti, comici parlare di sé e del mondo davanti a quei microfoni. Ci risulta quindi naturale pensare che chiunque sia davanti a uno di quegli stessi microfoni abbia qualcosa da dire. “Ci sarà un motivo se è lì, no?” ci domandiamo. La risposta – potrebbe stupire qualcuno – è no. Non necessariamente.
Attorno a un tavolo di legno in uno studio non troppo grande, caldo, con una sorta di tenda, un drappo rossastro, alle spalle dell’ospite, l’host è illuminato da un neon colorato con il nome del podcast. Sul tavolino, solo i microfoni; sia l’host che l’ospite indossano delle grosse cuffie nere. Pochi elementi che ritroviamo in tutti i podcast con una versione video.
La diffusione di clip social che imitano podcast è stata oggetto di analisi sia su TikTok che su YouTube, dove è stato giustamente notato che in certi casi le persone coinvolte non usano nemmeno il microfono nel modo giusto. Del resto, il microfono non serve nemmeno, è solo un prop di scena con cui simulare un ambiente riconoscibile ai più (così come lo sono le cuffie). Volendo immaginare una versione pre-internet di tutto questo, è come se un aspirante cantante di liscio, negli anni Novanta, avesse affisso nei paesini dei manifesti con un fotomontaggio che lo facevano sembrare seduto nelle poltroncine rosse del Maurizio Costanzo Show. Se “l’imitazione è la forma più sincera di adulazione”, la copia indiscriminata è la certificazione ufficiale dell’efficacia di un contenuto online. Dopo essere stato stravolto dall’invasione di Spotify, il mondo dei podcast è più omnicomprensivo e intermediale, come dimostra il crescente interesse di YouTube (la piattaforma video per eccellenza) in questo tipo di medium. È la conferma che i podcast hanno smesso di essere audioblogs e sono ormai altro, una categoria di contenuti talmente larga da essere ormai difficile da definire. Anche se, per qualche strana magia di internet, sappiamo tutti che aspetto ha.
Pietro Minto
Nato a Mirano, in provincia di Venezia, nel 1987; vive a Milano. Collabora con Il Foglio, Il Post e altre testate. Dal 2014 cura la newsletter Link Molto Belli.
Vedi tutti gli articoli di Pietro Minto